 EDITORIALE di Anna Armone
EDITORIALE di Anna Armone
Direttore responsabile - Esperta in Scienza dell’Amministrazione Scolastica
PRIVACY: Entro maggio 2018 la riforma del codice per adeguarlo alle nuove direttive europee
Nel silenzio assordante di quasi tutte le Pubbliche amministrazioni, si avvicina il mese di maggio 2018, data in cui entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo sulla privacy. Le istituzioni scolastiche sono poco attente a questo tema, anzi, mi correggo, lo affrontano con una leggerezza allarmante. L’Italia fa parte della Comunità Europea, ma la sua impostazione culturale sembra distante anni luce dalla visione culturale che sottende il tema della privacy.
Nel 2009 la Commissione europea ha iniziato l’elaborazione di uno studio articolato volto a valutare l’attualità delle regole di protezione dei dati personali contenute nella direttiva 95/46/CE (recepita dal d.lgs. 196/2003). Le conclusioni di questi studi, pur evidenziando la necessità di adeguare il complesso normativo ai notevoli cambiamenti intercorsi per effetto dell’evoluzione tecnologica (il cui ritmo cresce in modo esponenziale), hanno confermato la validità dei principi fondamentali della direttiva e l’opportunità di mantenere il suo carattere neutro sotto il profilo tecnologico.
Con la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo del 4/11/2010 denominata«Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell’Unione europea»si dava il via al percorso di riforma della direttiva 95/46/CE.
Nel testo si premetteva che«la direttiva del 1995 è una pietra miliare nella storia della protezione dei dati personali nell’Unione europea. Essa sancisce due antiche ambizioni ugualmente importanti del processo d’integrazione europea: la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, quindi anche del diritto fondamentale alla protezione dei dati, e la realizzazione del mercato interno, ossia, nello specifico, la libera circolazione dei dati personali».
La Commissione evidenziava anche che «la rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione hanno mutato profondamente il mondo in cui viviamo, ponendo nuove sfide alla protezione dei dati personali. Oggi la tecnologia consente di condividere agevolmente informazioni sui comportamenti e sulle preferenze, e di rendere pubblici a livello mondiale quantità di dati senza precedenti. I social network, con centinaia di milioni di membri in tutto il mondo, sono forse la più evidente ma di certo non l’unica manifestazione di questo fenomeno. Allo stesso tempo le modalità di raccolta dei dati personali si complicano e diventa più difficile individuarle».
A queste motivazioni si aggiungeva anche la verifica dell’insufficiente armonizzazione, tra i vari paesi europei, delle norme di protezione dei dati. La necessità di migliorare la certezza giuridica, ridurre gli oneri amministrativi e assicurare condizioni più omogenee per la gestione dei dati, soprattutto in considerazione della dimensione transnazionale di gran parte delle attività economiche, costituiva anch’esso pertanto un obiettivo primario del legislatore europeo.
Sulla scorta di queste azioni preliminari, il Paramento europeo, con la risoluzione del 6 luglio 2011, dava incarico alla Commissione di procedere alla definizione di un nuovo quadro regolamentare della materia.
Il nuovo quadro giuridico europeo, si configurava ufficialmente il 25 gennaio 2012, con due proposte legislative, il c.d. “pacchetto protezione dati” in quanto concepito come un unico insieme di disposizioni complementari da approvare congiuntamente:
una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati;
una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.
Il complesso percorso di approvazione degli atti legislativi dell’Unione si è concluso finalmente il 27 aprile 2016 con l’approvazione contemporanea del Regolamento (UE) 2016/679, (Regolamento generale sulla protezione dei dati - d’ora in poi RGPD) e della Direttiva (UE) 2016/680, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni.
Il Regolamento costituisce l’architrave di questo cambiamento: a decorrere dal 25 maggio 2018, data in cui lo stesso diventerà obbligatorio e direttamente applicabile, in tutti gli Stati membri dell’Unione europea si avrà una medesima base giuridica unitaria anziché le tante, diverse leggi di recepimento della precedente direttiva.
Il regolamento, in quanto fonte primaria, in base all’art. 288, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha portata generale ed è, a differenza della Direttiva, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Al contrario, la Direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta, per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma richiede una norma nazionale di recepimento che, in questo caso, dovrà essere adottata entro il 6 maggio 2018.
Nell’ambito della legge n.163 del 25/10/2017 per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2016-2017), è stata prevista la delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2016/680 (art. 11) e adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del RGPD (art. 13), fissando i seguenti principi e criteri direttivi:
abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (d’ora in poi Codice), incompatibili con le disposizioni contenute nel RGPD;
modificare il Codice limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel RGPD e coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni del RGPD;
prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito e per le finalità previsti dal RGPD;
adeguare il sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, vigente alle disposizioni del RGPD, con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni commesse.
Le norme relative all’adeguamento della disciplina al RGPD dovranno essere adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di delegazione.
Il RGPD lascia maggiori margini di autonomia ai titolari del trattamento pubblici e privati, rispetto al passato, diminuendo gli adempimenti preventivi al trattamento (eliminata la notificazione del trattamento) e le autorizzazioni preventive da parte dell’Autorità (la consultazione del Garante avverrà solo nei casi nei quali la valutazione di impatto privacy, effettuata dal titolare del trattamento, evidenzia che il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche). Questa maggiore autonomia è però, d’altro canto, compensata dal dovere di dimostrare, ogni qual volta si renderà necessario, la compatibilità al regolamento delle decisioni assunte.
Ciò comporterà quindi l’esigenza di disporre di qualificate risorse in grado di orientare le decisioni dei titolari del trattamento. In questo senso l’introduzione anche in Italia del Responsabile della protezione dei dati (RPD) costituisce una grande opportunità. Questa figura chiave, obbligatoria per i trattamenti effettuati dalle autorità pubbliche o da organismi pubblici, sarà chiamata a facilitare l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e dovrà svolgere un complesso ruolo di interfaccia fra il titolare o il responsabile del trattamento, gli interessati e il Garante. Questa nuova figura, che il regolamento richiede sia individuata in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati, costituisce il fulcro del processo di attuazione del principio di “responsabilizzazione”. Il diretto coinvolgimento del RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla fase transitoria, è sicuramente garanzia di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto. In questo ambito, sono da tenere in attenta considerazione i requisiti normativi relativamente a: posizione (riferisce direttamente al vertice), indipendenza (non riceve istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti) e autonomia (attribuzione di risorse umane e finanziarie adeguate).
Il sistema dell’istruzione si presenta alquanto debole e impreparato. La debolezza è nella capillarità strutturale del sistema. Sembra improbabile che in ogni scuola si possa individuare tale figura, considerato il livello di competenza che deve possedere e il ruolo esclusivo che deve svolgere. Sarebbe opportuno iniziare una riflessione sull’assetto del sistema scolastico per individuare i nodi sui quali porre questa nuova figura di supporto all’attività dei soggetti interni alla scuola, il titolare e il responsabile.
Ed ora veniamo al contenuto di questo numero della rivista. Francesco Nuzzacianalizza le modifiche al d.lgs. 165/2001 apportate dai decreti legislativi 74 e 75 del 2017. In particolare commenta la nuova regolazione dell’art. 40 individuandone i margini di rinnovamento e le conferme. Alla luce del nuovo testo ripropone la procedura di individuazione dei docenti di ambito, qualificando il ruolo del dirigente e, quello nuovo, del collegio dei docenti, così come richiama la procedura di attribuzione del bonus premiale ai docenti, riportando l’azione nella sfera della competenza discrezionale dirigenziale. Il pezzo si conclude con un richiamo alla nuova formulazione del procedimento disciplinare, ponendo l’accento sulla competenza dirigenziale all’irrogazione della sanzione della sospensione fino a dieci giorni, anche per il personale docente.
Antonio Marcellino, broker assicurativo, espone il modello della scelta del contraente in campo assicurativo, facendo riferimento alla categoria del broker, professionista che supporta l’amministrazione per la stipula dei contratti assicurativi. L’autore richiama le norme sulla trasparenza per sostenere la necessità di un procedimento ad evidenza pubblica aperto alla libera concorrenza e agli altri principi comunitari, al fine di garantire le famiglie contribuenti e l’interesse pubblico dell’Amministrazione.
Maria Grazia Accorsiaffronta il tema della quarta rivoluzione industriale e la sua relazione con tutti i contesti formativi, formali e informali. Nel corso della trattazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro esplicita un nuovo concetto di orientamento, “da intendersi sia come abilità e conoscenze che migliorano la capacità di fissare obiettivi (prendere decisioni, muoversi nel mondo, impegnarsi di volta in volta su obiettivi diversi, assumere apprendimento permanente come progetto di vita; sviluppo di self efficacy), sia come capacità di fare scelte realistiche, non avventate o etero dirette o basate su casualità, pregiudizi, illusorie rappresentazioni, ma fondate sulla conoscenza di sé e su una buona (meglio se diretta) conoscenza del mondo dell’istruzione, del lavoro e delle professioni”.
Vanna Monduccicompleta la relazione sul 7° SUMMIT sulla professionalità docente svoltosi ad Edimburgo nello scorso mese di marzo (la prima parte è stata pubblicata sul n. 2/2017). La panoramica è oltremodo interessante, in particolare con riferimento alla centralità riconosciuta alla qualità della professione docente che condiziona gli esiti degli studenti. Molti paesi stanno anche cercando di affrontare gravi difficoltà di reclutamento, che potranno essere superate solo se l’insegnamento diventerà più attraente sia finanziariamente che intellettualmente e se si potranno affrontare questioni relative al carico di lavoro e al benessere degli insegnanti. Un ulteriore punto di interesse è costituito dalla valenza riconosciuta al gruppo sociale degli insegnanti. TALIS 2015 ha esplorato il rapporto tra la leadership didattica e la creazione di comunità professionali di apprendimento che permettono agli insegnanti di collaborare e si impegnano in dialogo professionale costante con l’obiettivo di migliorare la pratica dell’insegnamento.
Nicoletta Tomba, che si occupa di comunicazione presso l’Area istruzione del Comune di Bologna, sintetizza in quadro chiaro e lineare il tema della comunicazione pubblica, istituzionale e non istituzionale. Benché la scuola non preveda una figura addetta alla comunicazione, una riflessione sul modello organizzativo da adottare e sui passi operativi da approntare, sembra opportuno e strumentale ad una progettazione strategica dell’offerta formativa e dei servizi.
Gabriella Zanetti, dirigente scolastico, racconta di un caso di conflitto tra il collegio dei docenti, il consiglio di istituto e il dirigente scolastico in merito all’annosa questione della riduzione dell’ora di lezione e alle modalità del recupero. La vicenda si snoda lungo il concetto di responsabilità, collegiale e individuale che investe tali decisioni. L’autrice riporta in modo molto analitico la posizione dell’Amministrazione scolastica e della giurisprudenza in merito alla qualificazione degli elementi di tale responsabilità, che si sviluppa nell’ambito dell’esercizio e realizzazione dell’autonomia scolastica. A valle delle decisioni sull’oggetto del conflitto c’è il diritto degli studenti alla prestazione del servizio che va sicuramente garantito.
Ivana Summaaffronta il tema delle conoscenze professionali come risorsa organizzativa nell’istituzione scolastica. Il ragionamento parte dall’assunto che deve esserci coerenza tra ciò che viene scritto in termini di norme, principi, valori, obiettivi e ciò che concretamente le persone fanno e che dovrebbero fare. Purtroppo, la costante richiesta del MIUR ai dirigenti scolastici di tenere sotto controllo la struttura formale facendo passare in secondo piano la trama relazionale ad essi affidata tacitamente, rappresenta un potente indicatore della capacità di conduzione di un’organizzazione complessa come le nostre scuole. E sono proprio i processi organizzativi relazionali che decidono del comportamento professionale delle persone. Partendo da questo assunto l’autrice afferma che le organizzazioni affidabili sono quelle capaci di “azione collettiva” e ciò vale anche per a scuola, che è un particolare contesto organizzativo che, per funzionare in modo unitario dovrebbe elaborare una sorta di“mente collettiva”,costituendosi come una vera e propria “comunità professionale”.
Domenico Ciccone conclude il primo ciclo annuale sull’analisi comparata della figura dirigenziale approfondendo il ruolo del capo di istituto in Finlandia. Il quadro che ne risulta è quello di una pragmatica realtà fondata sulla responsabilità sociale all’interno e all’esterno della struttura scolastica. Il ruolo della comunità locale si gioca su diversi fronti, quello della decisionalità rispetto all’individuazione dei dirigenti ma anche, principalmente, quello, del vero governo del sistema. Niente dirigenza all’italiana, niente stratificazioni normative e regolamentari. Una sana, semplice e responsabile gestione.
Giuliana Costantini, nella rassegna libraria, propone tre romanzi ad uso dei lettori anche nell’ambito di attività didattiche e un testo tecnico, a cura di Angelo Mari, sul recente decreto legislativo avente ad oggetto il sistema integrato 0-6 anni. Questo testo, in particolare, parte dall’esegesi del sistema e approda ad una serie riflessioni e di proposte che possono supportare questa fase decisionale della politica e dell’Amministrazione.
Il numero si chiude con le recensioni cinematografiche di Vincenzo Palermo. L’autore racconta di tre film estremamente interessanti. Il primo, Captain Fantastic, narra di un’utopia educativa, basata sul rapporto con la natura e valori fondamentali, che alla fine fa i conti con l’adattamento ad una vita borghese. Il secondo film, Okja, è un cartone che narra di una sorta di amore tra una bimba e un supermaiale. La bimba metterà a rischio se stessa, il proprio incontaminato eden e gli amici animalisti pur di liberare Okja dal mattatoio. È una sorta di denuncia contro il consumismo sfrenato.
Buon 2018 a tutti e alla nostra Scuola, in particolare. Ne ha proprio bisogno... . X





 Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni
Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni




.png)
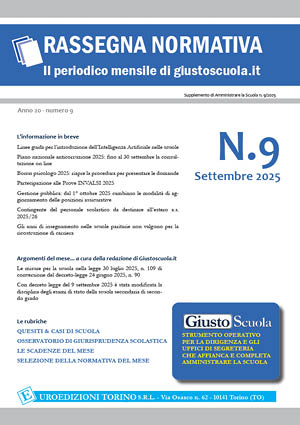
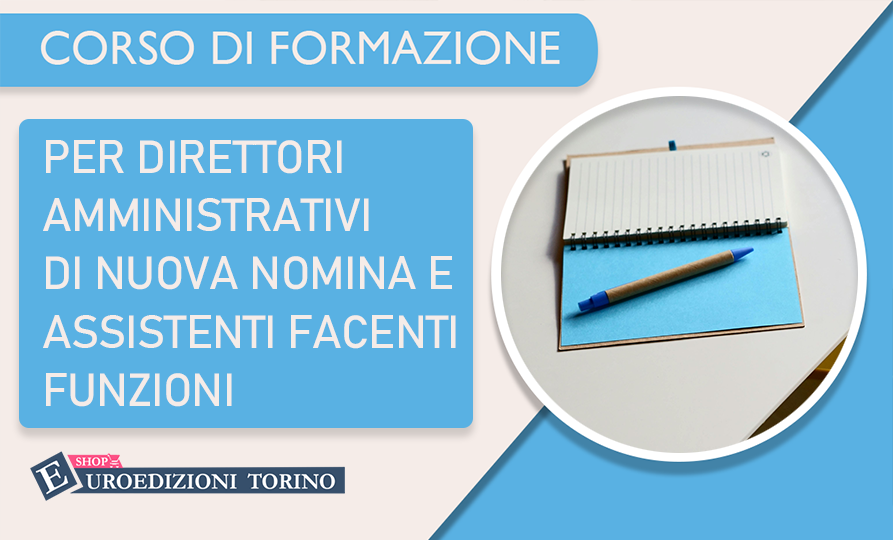 La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione on line dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.
La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione on line dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.










 Con il nuovo numero di
Con il nuovo numero di 

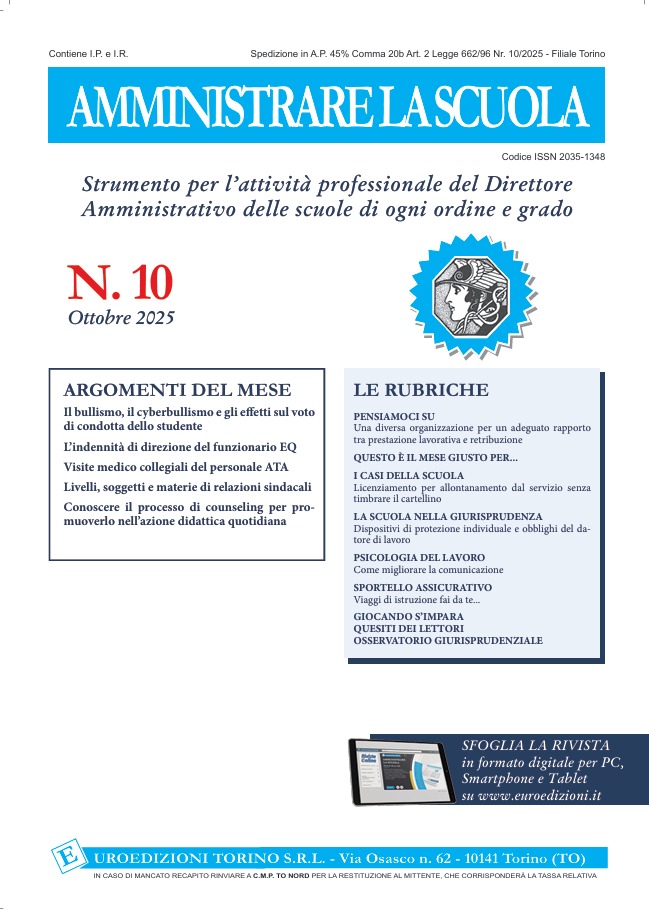


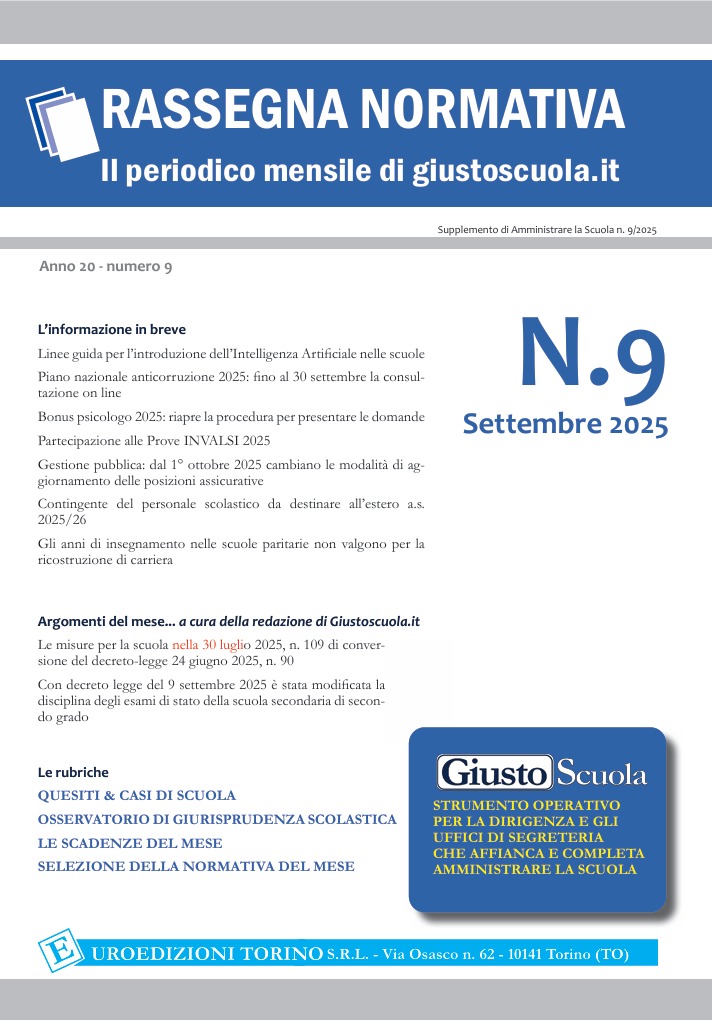
.png)







.jpg)





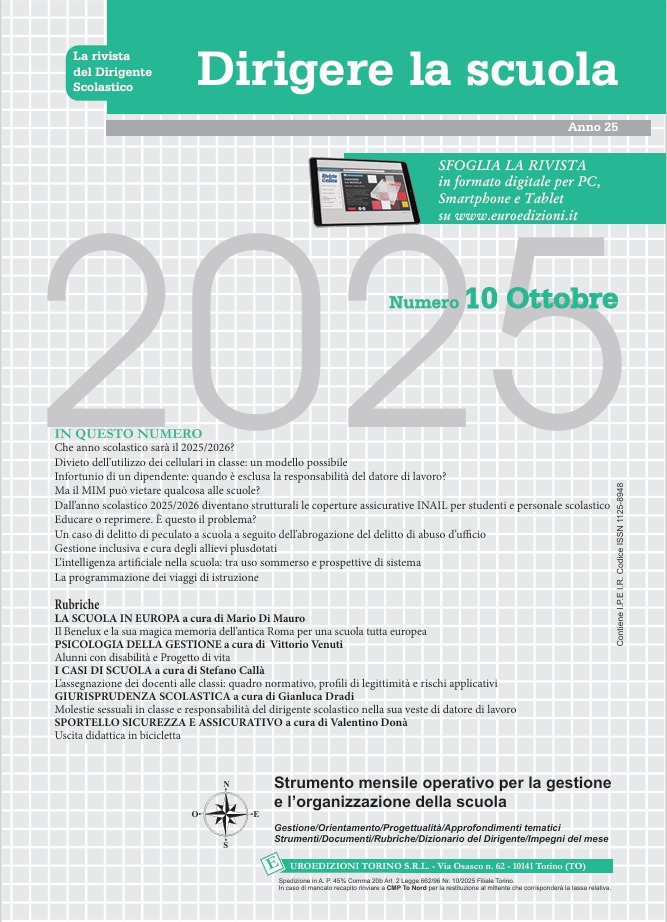
.jpeg)
.jpeg)
.png)





.jpeg)




